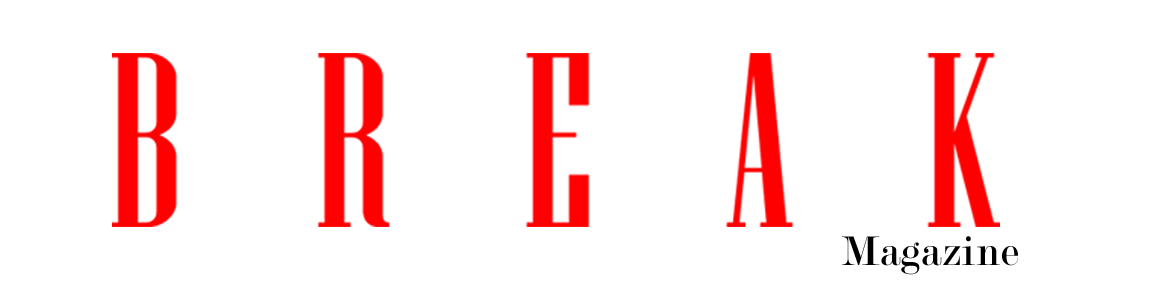Un volto di minatore, dietro al quale se ne intravedono altri due, sussulta su un bus; una bimba dorme avvolta nel suo maglioncino e si sveglia di soprassalto non appena l’automezzo si ferma; seguono altri volti ancora di uomini, per lo più vissuti, intensi, autentici. La camera si arresta infine sul volto di una bella e giovane donna, inquadrata di profilo, che pare dormire anch’essa.
Sono immagini dalla grande bellezza ed espressività visiva, anche se in formato quasi televisivo. Segue un’inquadratura dall’alto della città, dal formato più ampio, dove si stagliano molti edifici moderni appena costruiti, macerie e, più in fondo, vecchie casette consumate dal tempo. Le case della vecchia Cina. Segue una scena d’interni dove la donna di prima, filmata di spalle, si muove con eleganza, in un luogo popolare e affollato dove gli uomini si ritrovano per seguire un piccolo spettacolo. La voce di un presentatore ci informa che siamo nell’aprile del 2001.
La sequenza ha come sfondo musica pop e karaoke. Poi la donna s’introduce dietro una porta che nasconde una sala da gioco, presumibilmente clandestina. Qui la vediamo discutere con autorevolezza con un gruppo di uomini, e poco dopo capiamo che si tratta della donna di un piccolo boss locale. Senza descrivere tutto quello che segue, anche se importante, riveliamo però che la sequenza si conclude con la donna che prende in mano la pistola poggiata dietro di lei maneggiandola incuriosita. È un presagio di tutto quello che verrà dopo. Stacco sul nero dove i titoli di testa, che si erano interrotti, riprendono.
I figli del fiume giallo, il nuovo film del cinese Jia Zhang-ke presentato in Concorso all’ultimo festival di Cannes che esce ora in sala, è la storia di una donna, Qiao, e della sua ricerca assoluta d’amore. Una storia che copre tre momenti chiave nelle trasformazioni grandiose ma anche drammatiche subite dalla Cina: il 2001, quando le trasformazioni cominciano a essere tumultuose ma la vecchia Cina rurale che si sposta in biciletta o in bus è ancora forte; il 2006, anno in cui si è conclusa la costruzione della diga delle Tre gole, la seconda del mondo in termini di grandezza, opera monumentale che ha però devastato in parte l’ambiente, cancellato interi villaggi e disgregato intere comunità; e infine il 2018 in cui tutto si chiude, negli stessi luoghi ma completamente trasformati.
È un grandioso affresco che contiene altri affreschi, o meglio, un film che in qualche modo richiama e prolunga gli affreschi della Cina moderna che il regista ci ha offerto in circa vent’anni di lavoro. Quello di Jia Zhang-ke è più che mai un viaggio nel tempo, anche se temporalità e memoria (e il suo dissolvimento) sono stati sempre centrali nella sua filmografia. Oggi Jia Zhang-ke è considerato a livello internazionale uno dei più grandi cineasti viventi del cinema d’autore, uno dei pochi che possa essere paragonato ai grandi del passato per complessità, originalità e ampiezza di visione. Proprio per questo è necessaria, vista anche la struttura del film, una rilettura della sua opera passata. Ma il film è un capolavoro e il regista fondamentale. Tanto più che Jia Zhang-ke si va finalmente affermando anche in Italia, colmando così una lacuna e riducendo una distanza con altri paesi europei, grazie a nuovi distributori arrivati da qualche anno nel nostro mercato che hanno contribuito a ridurre il nostro provincialismo, che è quasi una prigione. Parola che non usiamo a caso, come vedremo.
Jia Zhang-ke è uno dei registi più significativi del cinema contemporaneo, ma in Italia si è rischiato di non conoscerlo. Se infatti un appassionato di cinema internazionale vi chiedesse se conoscete Hou Hsiao-hsien, cosa direste? Eppure il maestro taiwanese è comunemente ritenuto uno degli autori più importanti della generazione nata tra la seconda metà degli anni quaranta e la prima metà degli anni cinquanta del novecento. Non lo citiamo per caso, perché Hou Hsiao-hsien considera Jia Zhang-ke, nato nel 1970, come un figlio spirituale, per tanti motivi, tra cui quello di essere nati in ambienti umili: Hou Hsiao-hsien da ragazzo era praticamente un teppistello, la famiglia di Jia Zhang-ke è composta quasi solo da operai. Proprio gli operai sono al centro dell’amore di Zhang-ke per gli esseri umani e parallelamente al cuore della sua critica per il loro impoverimento, non solo materiale, causato dai processi capitalistici. Inoltre, tutti e due sono molto interessati alle arti e alla cultura dell’antica Cina come pure alle forme di creazione più d’avanguardia.
I grandi film ci guadagnano sempre a essere rivisti ed è particolarmente vero per la filmografia di Jia Zhang-ke
Ispirato da Hou Hsiao-hsien, Jia Zhang-ke da molto tempo ha come collaboratore alle musiche Lim Giong, musicista d’avanguardia della tecno-pop, figura centrale nella realizzazione di uno dei film più importanti degli ultimi decenni, Millenium mambo (2001) di Hou Hsiao-hsien. È forse il film paradigmatico del secolo che scompariva e di quello che si apriva, un film in cui il senso della temporalità si confonde forse definitivamente: la voce fuori campo della magica sequenza iniziale, una vera bolla sospesa al di fuori di ogni tempo, ci ricordava che i fatti raccontati accadevano dieci anni prima, nel 2001. I figli del fiume giallo è quindi forse, tra tutti i film di Jia Zhang-ke, il vero figlio spirituale del mitico Millenium mambo.
E torniamo a I figli del fiume giallo, un film profondamente commovente. Questa donna che attraversa le più grandi avversità – quasi eroica senza mai dare l’impressione di voler fare l’eroina – per proteggere il suo compagno, il gangster Bin, fino a sparare per lui, fino ad andare in galera per lui, è un personaggio unico. Senza cercare la lacrima facile, ma lasciando che questo straordinario e doloroso itinerario di donna, che il regista salda a quello della Cina, pervada lentamente spettatori e spettatrici durante la visione e forse dopo ancor di più.
I grandi film ci guadagnano sempre a essere rivisti ed è particolarmente vero in questo caso per la filmografia di Jia Zhang-ke. Il cineasta intarsia qui molti dei suoi film chiave e un po’ tutti i periodi della sua cinematografia. Si apre nella città di Datong, nello Shanxi, la regione dove il regista è nato, e qui siamo dalle parti, come ambientazione e tematiche, dei suoi primi film. Come Xiao wu (1997), che si svolge nella cittadina dove è nato, Fenyang, e narra la storia della deriva di un ladruncolo che non riesce a riciclarsi nei nuovi commerci al contrario di altri; Platform (2000), che copriva il decennio dal 1979 al 1989, cioè dalla Rivoluzione Culturale ai primi accenni della globalizzazione, mediante una compagnia teatrale in perenne spostamento; o Unknown pleasures (2002), che riprende il titolo del celebre album dei Joy Division: ambientato nel 2001 sempre a Datong, con sullo sfondo le Olimpiadi del 2008, è la storia di due ragazzi un po’ allo sbando che si lasciano andare alla deriva colorando con il pop di cui sono innamorati, dalla musica ai film, il grigiore quotidiano. Questo è il titolo che forse più rimanda (anzi, che ci riporta) a I figli del fiume giallo. La donna di cui sono innamorati si chiama infatti anche lei Qiao e come lei è la fidanzata di un gangster. Tutti grandi film presentati e spesso premiati a Venezia o Cannes, anche se sfortunatamente mai distribuiti nelle sale italiane.

The world (2004), il primo film del regista ad avere l’approvazione delle autorità cinesi e anche il suo primo film a uscire dalla regione d’origine, è ambientato in un parco a tema realmente esistente a Pechino dove sono riprodotti su scala ridotta tutti i grandi monumenti esistenti al mondo, dalla Tour Eiffel alla torre di Pisa, passando per il Big Ben di Londra e la Statua della libertà. Un film che coniuga come nessun altro la globalizzazione con i concetti di simulacro postmoderno, qui sinonimo di svuotamento di senso dei luoghi antichi e dei monumenti. E con lo stesso concetto di postmoderno, che ostenta quello che è colorato, patinato, perfetto. Ma non c’è umanità e i dipendenti del parco dormono in stanze strette e semibuie che sembrano quasi catacombe. Compresa la bellissima protagonista, un’artista che si esibisce nel parco, che cerca e sogna, insieme a un’amica russa, un altrove e insieme un’altra possibilità di vita.
Estetica pop
In questo mondo colorato e levigato, ma paradigmatico della falsificazione del mondo e degli esseri umani, abbiamo già ambienti ed estetiche pop al limite del kitch – grazie anche alla presenza di animazioni – che il regista trasfigura con sapienza e che ritroveremo in seguito negli ultimi film, in particolare in Al di là delle montagne (2015), praticamente un film di fantascienza visto che un segmento importante è ambientato nel 2025. Con Still life (2006), Leone d’oro al festival di Venezia, abbiamo invece il ritorno al grezzo, al cinema quasi da arte povera dell’inizio, alla concitazione popolare, vista l’importanza nel film della presenza di vari operai. La costruzione della diga delle Tre gole nei pressi del fiume Azzurro (o Yangtze), nella regione di Hubei, è un’impresa epica che dà luogo a un film che è quasi un kolossal del minimalismo, della vita quotidiana nella cornice di edifici che hanno qualcosa d’imperiale. Tra gigantesche costruzioni e demolizioni, che richiamano continuamente l’arte concettuale e le videoinstallazioni, fanno capolino incredibili visioni notturne. Più che fantascientifiche, sono espressione di una sorta di poesia della fantascienza. Qui il regista ibrida il documentario con le (video)installazioni, il movimento della vita con la contemplazione estatica, il neorealismo con l’avanguardia, Rossellini con Antonioni.
La Qiao de I figli del fiume giallo si (ri)trova nel 2006 inseguendo il suo uomo, uscito anche lui di prigione, spezzato per sempre da quanto gli è accaduto. Non è più uno jianghu, termine dal significato polivalente e complesso: indica una tipologia di malavita che si va perdendo, ma anche letteralmente, stando al regista, “fiumi e laghi” e, sul piano della filosofia cinese, “persone diverse”, atipiche. Qiao cercando esplora, e noi con lei, gli spazi della nuova città edificata sulle Tre gole. E subito si staglia una potente inquadratura dal basso, che abbraccia la città, nella sua grandezza, nel suo movimento incessante. Qiao, nel suo peregrinare, trova solo uomini meschini e intenti alla falsificazione della vita, a fare affari, tutti peggiori del suo amato Bin, che si rivela vigliacco ed egoista, ma anche sofferto, incerto e problematico.
L’unica figura maschile positiva è un uomo di trenta o quarant’anni, che millanta grandi progetti mentre invece è solo un piccolo commerciante. Lui crede fermamente negli ufo che sorvolano costantemente le Tre gole, uscendo o entrando nelle acque. In quella regione fin dall’antichità, a detta del regista, c’erano strane apparizioni. Oggi gli ufo, che esistano o meno, sono per Jia Zhang-ke il riflesso di antiche credenze e mitologie dal sapore poetico. Ma sono una bolla protettiva che questa persona si è creata per sopravvivere, per non cedere al suicidio o alla disperazione di tanti, operai o imprenditori, giovani o vecchi, che hanno fallito come Bin, e che Jia Zhang-ke ha raccontato mirabilmente in Il tocco del peccato (2013, premio per la miglior sceneggiatura a Cannes, prodotto dall’Office di Takeshi Kitano). Una bolla dove può credere agli alieni tra noi, impedendogli di divenire un alienato. Quantomeno in quel contesto. E proprio sulle apparizioni il cineasta costruisce una sequenza d’antologia, da guardare e riguardare nel buio e nel silenzio. Perfetta per afferrare quel “sentimento cosmico” di cui parla con lucidità quell’uomo. Perfetta per far sentire con estrema poesia un sentimento di solitudine e insieme di comunione che prende una validità universale. Perfetta infine per esprimere un’altra frase profetica di quell’uomo che illumina di senso non solo il film ma l’intera cinematografia di Jia Zhang-ke: “Quello che sappiamo è che siamo prigionieri dell’universo”. Cioè delle macchinazioni o delle costruzioni volute dagli uomini più potenti, invece di essere liberi da tutte le costrizioni, come recitava il titolo cinese di Unknow pleasures.
È una questione centrale, perché qui il regista introduce anche il tema della (video)sorveglianza sempre più invisibile. In conclusione, ibridando praticamente tutto, un’ibridazione fatta con lo sguardo dell’artista antico, riesce nel miracolo di trovare una nuova omogeneità con I figli del fiume giallo che racchiude, sedimentati, stratificati, tutti i suoi precedenti film – tra cui, nella parte iniziale, del materiale girato nel 2001 – e con essi emergono quasi vent’anni di storia della Cina. Il percorso inverso delle acque di Still life che ricoprivano progressivamente i vari strati della valle dove erano sedimentate antiche memorie di varia natura. Ma quasi come uno specchio di Al di là delle montagne, che si apriva nel 1999, proseguiva nel 2014 per poi concludersi nel 2025, un film con il quale forma un ideale dittico. Con la fondamentale differenza che I figli del fiume giallo si chiude nel presente, un presente dal futuro incerto, invece che nel futuro.
Si ha ormai l’impressione, come per nessun altro cineasta, di un unico superfilm, di una sorta di vecchia e insieme moderna moviola, o macchina del tempo con la quale si va avanti e indietro, in cui un tempo si confonde nell’altro, talmente quest’amalgama dal sapore onirico è riuscito. Il trait-d’union, il filo conduttore e forse anche il filo d’Arianna per dipanare il tutto, è lei, anzi, una Lei con la L maiuscola. Perché è sempre Zhao Tao – l’attrice che interpreta Qiao – che ritroviamo a interpretare tutte le donne nella filmografia di Jia Zhang-ke, a eccezione di Xiao wu. Donne fondamentali anche quando non sono il personaggio protagonista. Anche qui si pensa alla lezione di Michelangelo Antonioni, il più orientale dei cineasti occidentali: molti suoi film erano retti dalle interpretazioni di Monica Vitti. La donna regge e rilancia nel cinema di Jia Zhang-ke, ma certo il sistema-prigione che vuole vincere ha catene non solo molto forti ma anche nascoste.
Leggi anche: