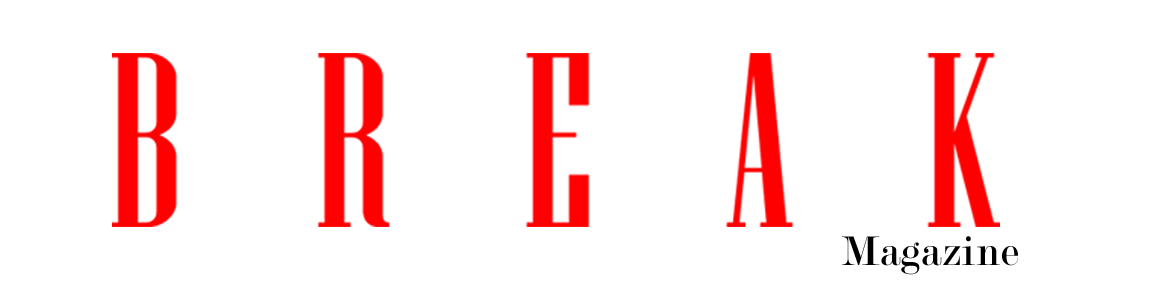Frank Sinatra e il cinema: vero amore o denaro e marketing?
In occasione dei 20 anni dalla morte di Frank Sinatra, conosciuto nel mondo come “The Voice”, La Stampa ripercorre la storia del divo e della sua famiglia.
L’uomo che visse due volte, Frank Sinatra. O forse anche di più. Cantante, una delle sua rinascite fu particolarmente clamorosa. E la dovette al cinema. Canzoni e film: procedono di pari passo. Carriere intrecciate e parallele, riverberavano l’una sull’altra. Soprattutto a partire da quel 1953 della rinascita.
Partiva da lontano però il rapporto di Sinatra con la Settima Arte. Dagli anni, bellici, in cui lo show business scopriva l’importanza del pubblico giovanile. Il Sinatra cantante fu uno tra i primi teen idol musicali. Come altre stelle della canzone, che sarebbero venuti nei decenni a seguire, tipo Elvis Presley o certi nostri divi della canzone negli anni 60, iniziò con non pregevoli ma molto profittevoli “musicarelli“: ne fece parecchi, dimenticabili e dimenticati (e da lui talora rinnegati), anche se con uno di questi, «Il denaro non è tutto», arrivò in zona Oscar per la miglior canzone.
Poi entrò nella scuderia della potente e poderosa MGM e le cose cambiarono. A Sinatra – ormai The Voice – fu affidato in un vero musical, «Due marinai e una ragazza», e un partner che per lui si sarebbe rivelato fondamentale, Gene Kelly, che gli insegnò i basilari della danza, e con cui avrebbe lavorato a più riprese: «Un giorno a New York» (polemiche a non finire durante la realizzazione perché il produttore aveva preferito alle canzoni del musical originario, di Leonard Bernstein, quelle del “più facile” Roger Edens: cosa che non impedì però al film di vincere l’Oscar) e «Facciamo il tifo insieme».
La strada del cinema per Sinatra sembrava tracciata. E molto bene. Poi MGM non rinnovò il contratto, lui incappò in due clamorosi insuccessi e l’avventura hollywoodiana parve chiudersi lì. Gli restavano incisioni e concerti, che Sinatra incrementò fino ad ammalarsene: la sua splendida voce incrinata, forse per sempre, mentre si aggiungevano problemi di tasse, di donne e di alcol. Non aveva 40 anni ed era già al capolinea?
Ma l’uomo non era di quelli che si arrendono. Mentre con tenacia tentava il rilancio come cantante (nuovamente in vetta alle hit parade), ci provava anche con Hollywood. Qui era la vera scommessa.
Fred Zinnemann, astro nascente reduce dall’Oscar per il miglior corto documentario, stava scegliendo il cast per «Di qui all’eternità»: bellico e drammatico, dai protagonisti illustri, Deborah Kerr, Montgomery Clift, Burt Lancaster. Per altri ruoli minori c’era incertezza. Sinatra fece di tutto per parteciparvi, anche se non era certo il film che ci si sarebbe aspettati da lui. Si disse che fosse stata la mafia (una leggenda a cui contribuì Puzo con il «Padrino»). Altri l’amicizia tra la moglie del produttore e Ava Gardner allora sposata con Sinatra. Altri ancora che si propose con un’offerta al ribasso del suo compenso. Sta di fatto che ottenne la parte. «Da qui all’eternità» sarebbe stato il film dell’anno agli Oscar: ne ottenne otto e uno fu per Sinatra. “Ol’ Blue Eyes” era tornato.
Iniziava la sua seconda vita. Poteva permettersi di tutto: musical («Bulli e pupe» con Marlon Brando, «Pal Joey» con Kim Novak e Rita Hayworth, in cui avrebbe cantato uno dei suoi più celebri hit, «The Lady Is a Tramp») e drammoni («L’uomo dal braccio d’oro»), commedie brillanti («Alta società») e kolossal avventurosi («Il giro del mondo in 80 giorni»).
Non avrebbe più smesso. Anzi. Stavano per arrivare gli anni d’oro del “rat pack”, il “branco di ratti” come li definì Lauren Bacall, moglie di uno di loro, Humphrey Bogart. Las Vegas come base, la mafia in controluce (circolavano sempre più gossip su Sinatra compromesso con Cosa Nostra), Frank come leader e tutti gli altri, Peter Lawford, Dean Martin, Sammy Davis jr, «Colpo grosso/Ocean’s Eleven», «Tre contro tutti», «I 4 del Texas», «I 4 di Chicago». Fu tramite Lawford, cognato di John Kennedy, che – si disse – la mafia fosse giunta a mettere Marilyn Monroe nel letto del presidente americano.
Era denaro e marketing, o vero amore quello di Sinatra per il cinema? La seconda, quasi sicuramente. In quegli anni avrebbe prodotto una decina di pellicole (non sempre un buon affare); una l’avrebbe persino diretta, «La tua pelle o la mia», film antimilitarista che la critica stroncò impietosamente. A Roma girò, negli anni della Hollywood sul Tevere, «Il colonnello von Ryan», cast misto italo-americano di cui faceva parte una giovanissima e pimpante Raffaella Carrà per cui si favoleggiò che il divo avesse un debole.
Intanto però gli anni d’oro erano finiti: Hollywood stava cambiando, pochi e radi i film da lì in poi, spesso nei panni di poliziotto. L’ultima apparizione Sinatra la fece in «Magnum P.I.», in un episodio del 1987, «Laura». Si disse che la produzione gliene avesse proposti tre in alternativa e che lui avesse scelto questo, dove era – appunto – un vecchio detective in pensione. Della serie era fan: ancora una volta si era proposto lui, a cachet zero. Ci piace pensare che, se avesse avuto tempo avremmo assistito all’inizio di una nuova fulminante carriera.
- Design