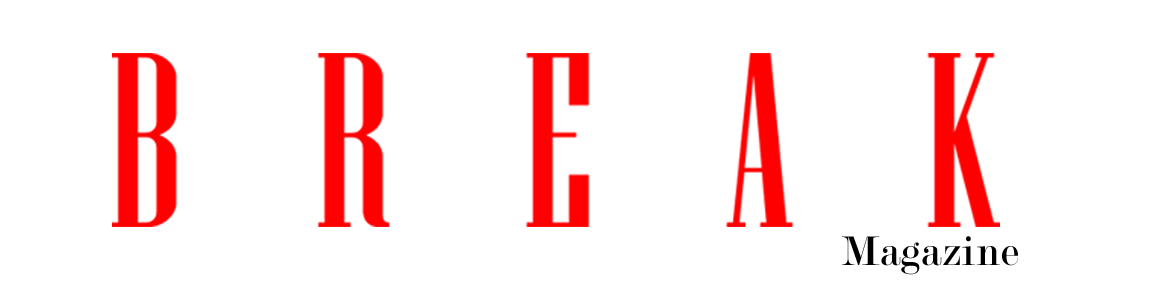Parlare di film di corruzione nel cinema italiano e interessante in quando sono state scritte diverse sceneggiature sul tema. Ma anche grandi ingegneri e architetti che hanno fatto parte di cast che parlano va di corruzione Antonio Valente, il grande il cinema vuol dire immergersi nel clima vitale e propositivo della prima metà del Novecento, quando dalle altre arti si guardava al cinema come ad un affascinante banco di prova, luogo deputato dei tempi moderni dove si poteva tentare di coniugare le discipline tradizionali e le novità tecnologiche portate dalla “dinamite dei decimi di secondo”. Il rapporto tra Valente e la produzione filmica è, peraltro, duplice: da un lato, l’uomo di teatro ha l’occasione di sperimentare su “altri palcoscenici” le sue capacità di scenografo e scenotecnico; dall’altro, l’architetto si trova – anche nel contesto cinematografico, come già nella pratica di progettista – nel cuore della politica del regime, che in quegli anni vide nel cinema un mezzo di propaganda strategico, per la sua capacità di diffusione e penetrazione. La storia dell’architetto prestato al cinema non si esaurisce tuttavia negli anni del fascismo, in cui egli conobbe un grande successo, ma parte da lontano e arriva fino agli anni Settanta.
Nell’attuale panorama cinematografico, americano nella fattispecie, ciò che spesso si avverte, consuete eccezioni a parte e senza cadere nella generalizzazione, è la mancanza della classica figura del “regista artigiano”, capace di spaziare tra i vari generi, senza magari connotarli di un tocco propriamente autoriale, ma lasciando il segno di una forte professionalità, tra impegno civile, rispetto della sceneggiatura e delle prestazioni attoriali, estremamente valorizzate semplicemente lasciandole fluire sullo schermo. Tutte caratteristiche proprie di Sidney Lumet, abile cineasta che ci ha lasciato lo scorso aprile, probabilmente tra i primi ad aver intuito il cambiamento profondo in atto nella società statunitense, la progressiva disgregazione dei valori fondanti, riuscendo a visualizzarlo sul grande schermo con estremo realismo, memore al riguardo della “lezione” televisiva, settore cui sono legati i suoi trascorsi registici, dopo alcune produzioni off Broadway e gli esordi come attore. In un certo senso ha anticipato quell’ondata di rinnovamento nota come New Hollywood, che, a partire dalla metà degli anni ’70, riscoprì l’essenzialità del cinema come messaggio e come concetto.

Serpico, ’73, tra tutti i suoi film, a partire dal debutto, La parola ai giurati, ’57, può considerarsi un’efficace ed emblematica sintesi tra valenza registica e caratterizzazione liberal, oltre che lucido compendio tra cronaca (la vera storia di un poliziotto del dipartimento di New York, in servizio dal ’59 al ’72) e lo script di Waldo Salt e Norman Wexler, su soggetto del romanzo omonimo di Peter Maas; sin dai titoli di testa, seguendo il tragitto verso l’ospedale di Frank Serpico (Al Pacino), agente investigativo della squadra narcotici di New York gravemente ferito nel corso di una retata, siamo trasportati all’interno di una struttura circolare: tramite un flashback, interrotto inizialmente dal montaggio alternato che ci mostra amici e superiori giungere al suo capezzale, possiamo conoscere le origini italiane di Serpico, l’ingresso nella scuola di polizia, giovane recluta, il desiderio di prendere contatto con la strada, con la realtà di ogni giorno, anche ricorrendo a inediti travestimenti e, soprattutto, la netta presa di distanza dai suoi colleghi, tanto come metodi che come rifiuto di ogni compromesso o bustarelle varie, scoprendo, nel passaggio da sezione a sezione cui è praticamente costretto dopo ogni denuncia, come, tranne rare mosche bianche, non ve ne sia uno che non sia “foraggiato”; il prezzo da pagare sarà alto, tanto a livello affettivo che nell’ambito del lavoro in cui crede fortemente, nonostante tutto, sino alla vittoria finale, sul piano morale, amaramente coincidente con la resa definitiva.
Lo stile asciutto, quasi documentaristico di Lumet, supportato dalla bella fotografia di Arthur J.Otniz, visualizza tanto le zone più degradate di una Grande Mela ormai marcia, vista spesso dal basso, tra grandangolo e teleobiettivo, quanto, ripagato dalla superba resa recitativa di Pacino, la schietta naturalità di un antieroe, individuo fiero della sua primigenia purezza, che cerca di preservare viva ed integra alimentandola di quegli ideali che ha coltivato sin da bambino, mantenendo una propria identità, morale e culturale, e riuscendo a dare un significato alla propria attività, facendo leva su una diversità contrapposta alla triste normalità dell’ambiente che lo circonda; allontanandosi a volte dai fatti reali, spingendo ossessivamente sul pedale della corruzione ad oltranza, il regista opta per una schematica, netta, distinzione tra bene e male, comunque, nella sua trasparenza e linearità, estremamente funzionale a creare un coinvolgimento, anche empatico, con il protagonista. E non manca un certo humour dal sapore acremente sarcastico, capace di condensare il senso del film in una sola battuta: Chi si fiderebbe di un poliziotto che non prende la busta?