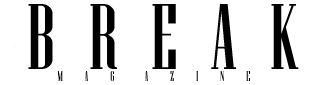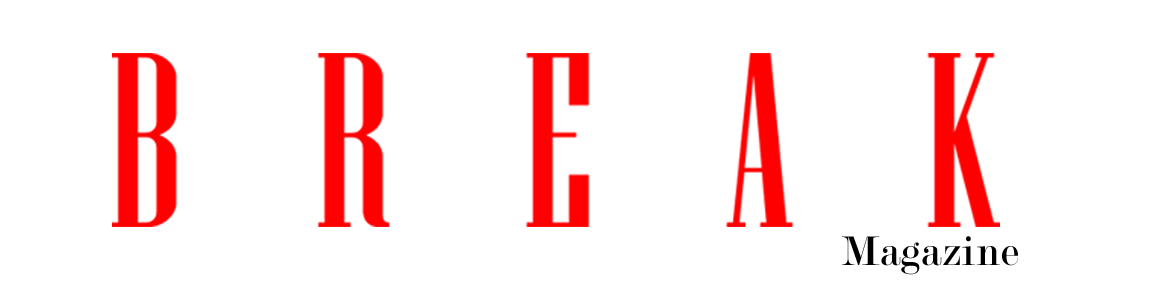l 2017 è stato uno di quegli anni che l’oreficeria italiana archivierà fra i positivi: secondo l’Istat, infatti, la produzione è salita del 15,6%, il fatturato dell’8,9%, le esportazioni del 12% dopo il calo del 4,2% nel 2016. A far da traino è stato anche l’aumento della domanda globale di gioielli di oro, del 4% in quantità secondo il World Gold Council.
Eppure, e a questo settore il gioco di parole si adatta perfettamente, non è tutto oro quel che luccica. «I numeri dicono molto, ma non tutto – spiega Gabriele Aprea, presidente del Club degli Orafi, l’associazione di cui sono membri 21 aziende italiane -. La crescita dello scorso anno è stata trainata in gran parte dall’inaugurazione della grande manifattura Bulgari a Valenza, a marzo. Come è successo con Pomellato e con Buccellati, gruppi esteri hanno rilevato i marchi più importanti, portando all’estero fatturato e utili e lasciando in Italia solo una piccola parte della ricchezza prodotta».
Nella classifica degli incrementi dell’export, infatti, il primo Paese è proprio la Francia di Lvmh, gruppo al quale Bulgari fa capo, con un aumento del 33% , pari a quasi 190 milioni in più rispetto al 2016. Al secondo posto la Turchia (+29%), seguita da Stati Uniti (+19,5%). Ottimi risultati anche per la Svizzera (+15,7%), ancora primo Paese di destinazione della produzione italiana, e Hong Kong (+16,2%), entrambi mercati-hub dai quali poi i preziosi viaggiano verso altre mete. Ancora in calo, invece, del 3,4% il secondo Paese di destinazione, gli Emirati Arabi Uniti: negli ultimi quattro anni l’export è calato del 30%, con una perdita di 380 milioni: «Le tensioni politiche locali ne sono la prima causa – aggiunge Aprea – come accade in Russia».
La ricerca di nuovi mercati, o l’approccio ai più promettenti, ma anche i più difficili, come quelli asiatici, resta un miraggio per le aziende italiane, distribuite su un tessuto polverizzato: secondo gli ultimi dati di Intesa Sanpaolo, presentati nel 2017 a Vicenzaoro, le imprese sono oltre 25mila, con più di 70mila addetti, dunque con una media di 2,8 ognuna. Più che piccole, dunque, micro-imprese, che non riescono a reagire alla potenza economica e comunicativa dei grandi brand e gruppi.
«Queste dimensioni impediscono di fare investimenti per la crescita anche del proprio brand, con il risultato che la maggior parte resta terzista, subendo a volte anche le imposizioni di prezzo dei grandi – spiega il presidente -. Anche le fiere sembrano ormai obsolete, dobbiamo organizzare un nuovo genere di evento in cui ci siano i marchi più importanti accanto ai più piccoli, con i primi a far da traino per i buyer, come accade già per la settimana della moda o il Salone del mobile. Si potrebbero coinvolgere anche altri settori delle eccellenze made in Italy, e il nostro recente ingresso di Altagamma potrebbe supportare questo progetto. Siamo un’eccellenza mondiale, dobbiamo crederci. Altrimenti quello che sappiamo fare così bene soccomberà ad altre logiche e alla concorrenza di altri Paesi».
- Design